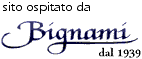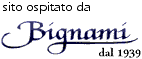La legge 895 del 1967 includeva nella nozione di armi
da guerra o tipo guerra, soggette alla normativa speciale, oltre alle
armi vere e proprie, gli esplosivi di ogni genere, gli aggressivi
chimici o altri congegni micidiali.
La legge 110 del 1975 elencava fra le armi da guerra, oltre alle armi
vere e proprie, "le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli
aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici
micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o
incendiari".
Le due norme erano scritte male, come sempre avviene quando non
si riesce a combinare il linguaggio del giurista con quello del
tecnico. Ad esempio chi scrisse la norma del 1967 non sapeva che per il
testo unico di pubblica sicurezza rientrano fra gli esplosivi anche le
munizioni per armi comuni, gli artifici pirotecnici, la polvere da
sparo; tutti prodotti i quali, anche se quasi sempre assoggettati a
controllo di pubblica sicurezza, mai sono stati considerati
meritevoli di essere inquadrati, come regime, sanzioni e pene, fra i
materiali da vietare totalmente ai privati, comminando pene draconiane.
Nella stessa legge restava poi, come pura espressione verbale la
nozione di congegni micidiali; neppure si capiva ad esempio se una
bomba rientrava fra gli esplosivi o fra questi congegni.
La legge del 1975 cercava di essere un po' più precisa, richiamava
espressamente le bombe, ma precisava che gli ordigni micidiali dovevano
essere di natura bellica; aggiungeva poi le bottiglie e gli involucri
esplosivi o incendiari.
Purtroppo anche questa volta i giuristi che scrivevano la norma hanno
usato belle parole molto vacue! Ed è ormai chiaro a tutti che
l'articolo 1 della legge 110 ha commesso l'errore di voler trovare
un'unica definizione di arma o prodotto da guerra che ricomprendesse
tutto, dal missile intercontinentale alla cartuccia da caccia; ricerca
ovviamente del tutto vana e che ha portato solo ad una gran confusione
fino alla legge sui materiali di armamento del 1990 che ha portato un
po' più di chiarezza tecnica.
Rimane quindi della legge 110 la nozione molto oscura di congegni
militari di qualsiasi natura; con un po' di sforzo si può immaginare
che il legislatore intendesse riferirsi principalmente agli ordigni
esplosivi casalinghi come, ad esempio, una pentola a pressione riempita
di chiodi ed esplosivo; ma, con lo stesso sforzo mentale si potrebbe
anche pensare che essa rientri fra gli involucri esplosivi. Certo che
il termine congegno è molto generale e quindi potrebbero rientrare in
esso anche quelle trappole della guerriglia fatte con tronchi chiodati,
con lacci, con pietre, ma dubito molto che il legislatore sapesse della
loro esistenza!
La nozione di involucri esplosivi o incendiari è ancora più misteriosa;
un involucro esplosivo non può essere altro che una bomba; se un
attentatore prende quattro candelotti di dinamite, ci inserisce un
detonatore e fa un bel pacchetto con carta e nastro adesivo, forse sarà
un involucro per chi lo guarda, ma per un tecnico rientra in tutto e
per tutto nella nozione di bomba. Quasi impossibile capire che cosa sia
un involucro incendiario; a me vengono in mente solo quei prodotti
usati per avviare il fuoco nei grill o una scatola di fiammiferi. Non
esistono involucri incendiari, ma solo prodotti incendiari i quali
ovviamente sono confezionati in qualche modo, a meno che non si voglia
sostenere che una tanica di benzina è un involucro incendiario
severamente vietato.
Il legislatore ha infine regolato, assieme agli involucri, le bottiglie
esplosive o incendiarie, creando ulteriore indegna confusione
linguistica e tecnica. Le bottiglie esplosive non esistono. Se uno
prende una bottiglia e la riempie di esplosivo e ci mette un innesco
crea una bomba vera e propria e poco importa se le schegge saranno di
vetro invece che di acciaio; di fronte a un esplosivo potente poco
importa se esso viene inserito a scopi delittuosi in una scatola di
cartone o in un contenitore di acciaio: sempre di una bomba si tratta,
la cui micidialità può essere maggiore o minore a seconda di dove è
collocata e dei componenti.
Rimangono quindi da esaminare le bottiglie incendiarie; è ormai
pacifico che il legislatore intendeva riferirsi alle cosiddette bombe
molotov (e bene avrebbe fatto chiamarle con questo nome). Esse sono
costituite da una bottiglia di vetro piena di sostanza infiammabile, di
solito benzina, e ben tappata, al cui esterno vengono legati una corda
o un nastro o uno straccio, pure bagnati o impregnati di una
sostanza infiammabile; al momento dell'uso si accende l'innesco esterno
e si lancia la bottiglia contro il bersaglio; la bottiglia, se urta
contro un corpo duro (carro armato, autoblinda, automobile, pavimento,
eccetera), va in frantumi, proietta schizzi di benzina verso l'alto e
attorno di sé, essa si infiamma e provoca una fiammata durevole. La
bomba molotov è molto pericolosa sui veicoli perché la benzina penetra
all'interno di essa bruciando chi vi è dentro, e contro le persone
perché può bagnare i loro abiti e trasformarle in una torcia.
Ho precisato che si tratta di bottiglie di vetro perché è il materiale
più ovvio e sicuro da usare. Però non si può escludere che esistano
altri materiali che all'impatto si frantumino creando effetti analoghi;
in teoria si potrebbe anche pensare ad un palloncino di gomma ripieno
di benzina, ma direi che in questo caso abbiamo forse trovato proprio
uno di quei misteriosi involucri incendiari di cui parla il legislatore.
Ciò premesso sorge il problema se il legislatore abbia ricompreso fra i
materiali da guerra qualsiasi bottiglia o involucro contenente sostanze
incendiarie, oppure se egli si sia riferito solo ai prodotti micidiali.
Il dubbio poteva sorgere nel 1975, ma ormai è superato da una regola di
valore generale stabilita dalla Cassazione in materia di esplodenti, ma
sicuramente applicabile a tutti i prodotti delle leggi del 1967 e del
1975: non può essere considerato una bomba un oggetto con dentro una
quantità minima di esplosivo (ed infatti gli inneschi per le cartucce
sono del tutto liberi) e una bottiglietta tipo campioncino di liquori,
non potrà mai funzionare da bomba molotov.
Fui il primo in Italia a sollevare il problema della differenza tra
esplosivi micidiali e non micidiali. Con ordinanza 10 aprile 1978,
quale giudice istruttore del tribunale di Bolzano, sottoposi il
problema alla Corte Costituzionale. Il caso era indicativo della totale
assurdità della giurisprudenza fino ad allora adottata dai giudici in
quanto si trattava di un tizio che aveva smontato alcune decine di
cartucce (la cui detenzione illegale e punita con una piccola ammenda,
oblabile) conservandone la polvere in essa contenuta e si trovava
imputato di detenzione di esplosivi, punita con un anno di reclusione!
La corte costituzionale, con sentenza 19 marzo 1986 numero 62, prendeva
atto della incongruenza, ma poi concludeva che i giudici che dovevano
interpretare la legge ben potevano adattarla alla situazione concreta.
A seguito di ciò la Cassazione a sezioni unite, con sentenza numero
10901 del 19 aprile 1986 stabiliva quanto sintetizzato nella
seguente massima:
La deroga alla disciplina generale ex art. 678 cod. pen. sulla
fabbricazione e commercio e quindi detenzione abusiva degli esplosivi
operata dalla normativa speciale ex leggi 2 ottobre 1967 n. 895, 14
ottobre 1974 n. 497 e 18 aprile 1975 n. 110 è limitata alle condotte
aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li
assimilino alle armi e specificamente alle armi da guerra, tali cioè
che il loro uso possa produrre morte e comunque offesa alla vita e
all'incolumità personale, mentre per le condotte aventi ad oggetto quei
prodotti esplosivi che di detta potenzialità e destinazione siano
ontologicamente sprovvisti si applica la normativa generale che le
qualifica reati contravvenzionali. (nella fattispecie è stata ritenuta
la sussistenza del reato di cui all'art. 678 cod. pen. in relazione
alla illegale detenzione di 430 "tracchi").
Seguivano quindi anni di sforzi della Cassazione per cercare di afferrare la distinzione concreta tra esplodenti micidiali.
La giurisprudenza successiva, fino al 1986, era praticamente costante
nell’affermare che le contravvenzioni previste dal codice penale agli
artt. 678 e 679 dovevano ritenersi abrogate e che ogni reato
concernente gli esplosivi doveva essere punito come delitto. Non
mancavano però massime che con maggior equilibrio affermavano che la
micidialità andava accertata caso per caso. Questa giurisprudenza
portava a conseguenze assurde perché finiva per punire con pene
draconiane condotte del tutto irrilevanti ai fini della lotta alla
criminalità: il tabacchino che vendeva qualche fuoco d’artificio
carnevalesco, il cittadino che li acquistava, il fochino che deteneva
un po’ di miccia, il cacciatore che deteneva un po’ di polvere da
sparo, ecc.
Dal 1984 in poi la giurisprudenza mutava e, in perfetta contraddizione
con quanto affermato fino ad allora in una serie di massime degna del
museo degli orrori giuridici, dichiarava che il concetto di
micidialità, che l’art. 1, L. n. 895/1967 sembrava riferire solo ai
congegni, andava invece riferito anche agli esplosivi; di conseguenza
erano delitti solo i reati riguardanti quegli esplosivi che per
qualità, quantità, confezionamento, destinazione di fatto, erano da
considerare idonei a produrre la morte o rilevanti effetti distruttivi
o, come detto in una sentenza delle Sezioni Unite del 1986, finalmente
giunta a risolvere il dilemma, tali che il loro uso possa produrre
morte o comunque offesa alla vita e all’incolumità personale. Gli altri
esplosivi, più genericamente ricondotti alla più generale categorie
delle materie esplodenti, continuavano ad essere regolati dagli
articoli del c.p. e del T.U. di P.S.
Se la prima giurisprudenza esagerava nell’applicare in troppi casi la
normativa del 1067, la seconda esagerava nella direzione opposta e non
risolveva granché perché affidava al giudice la soluzione di delicati
problemi di fatto, con necessità di accertare la pericolosità di un
prodotto esplodente e lo scopo della detenzione, in una materia in cui
i giudici hanno scarse nozioni e i periti esperti sono una vera rarità.
Si consideri, ad esempio, che un detonatore che contiene una quantità
minima di esplosivo, non è di per sé micidiale, ma è il componente
essenziale per provocare l’esplosione di una carica di esplosivo; si
consideri ancora che la polvere da sparo è di libera detenzione se
caricata entro 1000 cartucce da caccia (da cui può essere recuperata
facilmente), diventa materia esplodente se contenuta entro artifici
pirotecnici e diventa un esplosivo micidiale se confezionata in un
ordigno. Il legislatore perciò avrebbe dovuto distinguere tra prodotti
la cui detenzione illegale non poteva essere in alcun modo
giustificata, da prodotti destinati invece ad usi comuni e stabilire
pene differenziate in relazione alla pericolosità della condotta,
tenendo conto anche dello scopo del reo (diversa è evidentemente la
situazione del fochino che non distrugge un po’ di esplosivo per usarlo
il giorno dopo, da quella del fochino che lo conserva per rivenderlo a
criminali).
I gravi limiti di questa giurisprudenza sono dovuti al fatto che essa
ha voluto fondarsi su parametri di micidialità largamente opinabili e
soggetti a mutare a secondo della destinazione dell’esplosivo e che
essa ha preteso di trovare un’unica definizione di esplosivo da usare
sia per applicare le norme sulla lotta alla criminalità, sia per quelle
concernenti la prevenzioni di infortuni. Un esempio chiarirà meglio i
problemi.
Una bomba carta (involucro di carta robusta, riempito con polvere nera
da sparo o altro composto similare, legato con filo robusto) è un
petardo da ricomprendere tra gli artifici pirotecnici e quindi, per
destinazione naturale non è destinato ad offendere e non ha quindi
caratteristiche micidiali. Ciò non toglie che già un petardo contenente
50 grammi di polvere può portare via una mano e che un petardo di due
etti crea nel terreno un cratere di una decina di centimetri di
profondità ed è sicuramente micidiale: esso può essere usato per
compiere un attentato contro una persona o per sfondare una porta e il
suo contenuto può essere utilizzato per confezionare una bomba con
chiodi e frammenti.
Si consideri ancora che la legge consente di detenere senza particolari
controlli, salvo la denunzia, fino a cinque chili di polvere nera da
mina o da sparo; ciò significa che il legislatore non la ha di certo
classificata tra gli esplosivi micidiali e nessuno si sognerebbe di
condannare altrimenti che per una contravvenzione, il fochino che
avesse in casa un chilo di polvere da mina. Diverso però dovrebbe
essere l’atteggiamento del giudice se la polvere venisse trovata
confezionata in un petardo o semplicemente detenuta da un noto
attentatore.
D’altra parte però, ai fini della prevenzione degli infortuni, le
misure di sicurezza da adottare sono alquanto modeste in quanto i
petardi adeguatamente confezionati non esplodono per simpatia e, anche
in caso di incendio, scoppiano uno ad uno e non cumulativamente.
Si dovrebbe quindi concludere che la scelta tra l’applicare le norme
contro la criminalità o le norme sulla sicurezza dovrebbe essere basata
non sulla natura dell’esplosivo, ma sulla verosimile probabilità che
esso venga o meno destinato ad usi criminosi.
Molte delle più recenti sentenze hanno correttamente colto queste
esigenze, ma non si sono ancora poste il problema se le nome della
legge speciale si applicano solo quando vi è il pericolo di un uso
criminale degli esplosivi oppure anche quando vi è solo il pericolo di
infortuni gravi.
Inoltre è altrettanto chiaro che il tipo di micidialità richiesto è
quello tipico prodotto da un prodotto esplosivo; un detonatore che
scoppi in mano può provocare lesioni solamente alla mano: tipiche
lesioni da esplosivo ad alta velocità, ma non certo micidiali; se però
uno se lo fa scoppiare in un orecchio o in bocca, la sua morte è molto
probabile, ma basta ciò per dire che un detonatore singolo è un
esplosivo micidiale? Direi proprio di no in quanto la micidialità
deriva da un uso del tutto anomalo; vi è un'infinità prodotti chimici o
di congegni che se usati in modo anomalo sono pericolosi per la vita
umana, ma che non possono essere considerati micidiali (spara chiodi,
lancia arpioni ecc.)
A questo punto è facile trarre le conclusioni: è ormai chiaro che la
nozione di micidialità non si applica soltanto agli esplodenti ma anche
ai congegni esplosivi e non vi è nessuna ragione logica al mondo per
ritenere che essa non si debba applicare anche agli ordigni o congegni
incendiari.
Le bottiglie incendiarie sono severamente vietate non in quanto possono
provocare un incendio, poiché altrimenti si dovrebbe punire in modo
ancora più grave chi, allo stesso scopo, detiene una tanica di 20 litri
di benzina. Esse sono state assimilate agli ordigni esplosivi proprio
perché la loro possibile micidialità deriva dal fatto di poter essere
lanciate e di potersi frantumare all'impatto con effetti lesivi gravi
per una persona che sia investita dagli spruzzi. Di certo non
rientrerebbe tra le bottiglie incendiarie una bottiglia di plastica la
quale, tra l'altro, neppure potrebbe incendiarsi se non in modo
lentissimo e tale da consentire a chiunque di allontanarsi di qualche
passo da essa.
Ma non può rientrare fra di esse neppure una bottiglia di vetro con
l'innesco di accensione che contenga una quantità di benzina tale da
non creare pericolo di vita per chi venga investito dalla modesta
fiammata che si può realizzare.
".